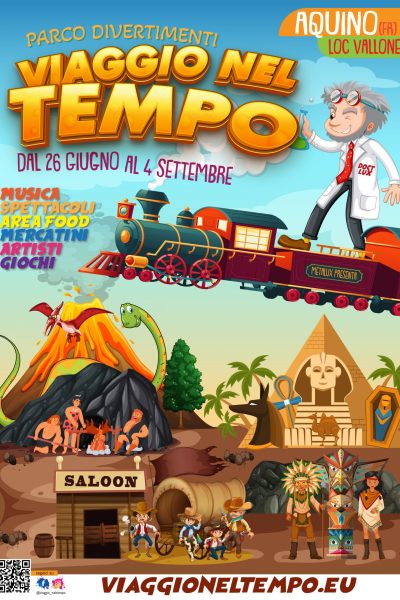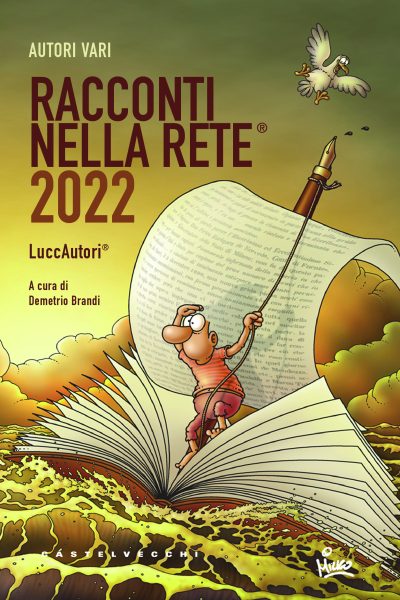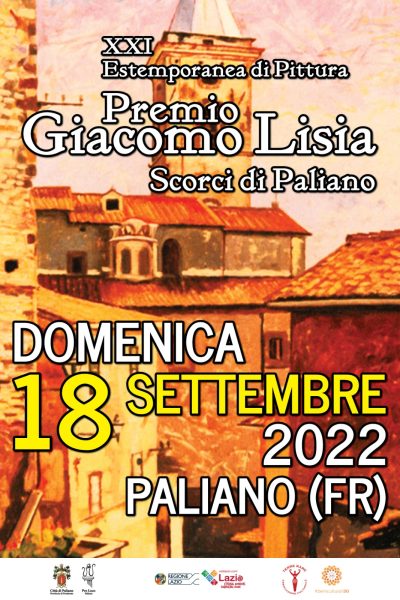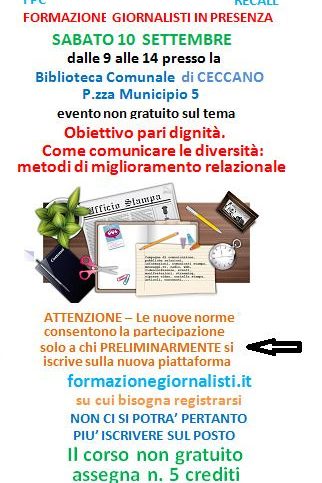Amministrazione della Blockchain una scelta tecnica o una scelta politica. Quis costodiet custodes?
politica. Quis costodiet custodes?
di Andrea Barella, Socio Aidr, Head of trading di Banca
Intermobiliare e Research fellow presso International University
College of Turin

Contesto storico
Negli anni 90 del secolo scorso nacque un movimento culturale definito
Cyberpunk che coniugava attenzione per la tecnologia avanzata e
volontà di ribellione o quanto meno cambiamento radicale dell’ordine
sociale. Questa sottocultura influenzò vari aspetti delle arti e delle
scienze. Il mondo letterario e artistico ma anche il mondo
informatico. Gli attivisti del mondo dell’information tecnology
appartenenti a questa corrente svilupparono, tra le altre, l’idea di
utilizzare la crittografia per migliorare la privacy delle persone.
Facendo un salto cronologico in avanti fino al 2008, ci troviamo
durante la crisi economica che porta molti dissesti finanziari tra cui
il fallimento di Lehman Brothers. La fiducia dei cittadini verso il
sistema finanziario è minima, poca fiducia riscuotono anche gli
organismi che avrebbero dovuto gestire ed evitare questa crisi,
governi, banche centrali e enti sovranazionali. L’opinione pubblica
ritiene che, da un lato gli enti di garanzia abbiano perso il
controllo e dall’altro che i costi dei salvataggi delle aziende
private saranno pagati dallo stato e quindi dai cittadini.
Questo è il contesto quando nel 2009 Satoshi Nakamoto, prima annuncia
all’interno di una mailing list di matematici crittografi il suo
progetto, e poi inizia la storia della blockchain (Blockchain
maiuscolo, a quei tempi), propagando nella rete embrionale di Bitcoin
il primo blocco, il genesis block. Satoshi insieme alla evidente
rivoluzione tecnologica si premura di chiarire che è in atto anche una
rivoluzione politica o quanto meno di politica economica. Al di là dei
contenuti innovativi che possono essere compresi da esperti
informatici, riporta a chiare lettere e a futura memoria nella
Coinbase (la stringa di testo libero all’interno del blocco) “The
Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”
ovvero “Il Cancelliere dello scacchiere ipotizza un secondo
salvataggio per le banche”, titolo del quotidiano The Times di quei
giorni. Se uniamo questa dichiarazione alla politica monetaria di
Bitcoin (passiva e predefinita) diventa esplicita la volontà di
Satoshi di creare un sistema monetario indipendente dalla gestione
politica e governativa.
La situazione attuale
A distanza di 12 anni vediamo come si è evoluto quell’intento.
Quando si legge o si parla di blockchain l’immaginario collettivo per
lo più ipotizza che il suo funzionamento sia stato codificato dal suo
inventore nel 2008 e da allora di fatto immutabile, sia negli aspetti
più prettamente tecnici (es. la sicurezza crittografica) che nei
parametri economici (es. inflazione). Un preconcetto molto lontano
dalla realtà dei fatti.
La blockchain di Bitcoin è un database gestito da un software, tale
software è freeware e ha numerose versioni (attualmente 8)
compatibili, gestite da altrettanti team di sviluppo, che apportano in
continuazione modifiche per, a loro giudizio, migliorare il
funzionamento della rete e del database.
Gli utilizzatori di questi software sono gli utenti dell’ecosistema:
– Miners, che lo usano per aggiornare la blockchain con blocchi di dati validi
– Software house che creano programmi che si appoggiano alla
blockchain (es wallet o exchange)
– Utenti generici, anche semplici privati cittadini, che usano il
software per detenere una copia della blockchain sul proprio server
Quando gli sviluppatori realizzano modifiche che incidono in maniera
più pesante sulla logica di evoluzione della blockchain realizzano dei
così detti “fork” (inteso come biforcazione non forchetta), in quanto
da quel momento in poi gli utenti che usano la versione vecchia e
quelli che usano la versione nuova creano due blockchain separate e
diverse (con un passato comune) e ai nostri fini, di fatto, due
criptovalute. Non tratteremo qui i dettagli tecnici che differenziano
soft-fork da hard-fork, diciamo solo che uno allarga i parametri,
quindi i blocchi precedenti sono compatibili con le nuove regole
mentre il secondo propone dei parametri più limitati, quindi i vecchi
blocchi non sarebbero compatibili con le nuove regole.
Ai nostri fini invece è interessante sapere che esistono due tipi di
fork, quelli condivisi, dove tutta o la maggior parte della comunità
accetta la modifica, e quelli contenziosi, dove la comunità si divide
in due gruppi dove anche il più piccolo dei due è sufficientemente
numeroso (utenti, miners, sviluppatori) da sopravvivere.
Esempi rilevanti di fork contenzioni sono:
Nel 2018 alcuni sviluppatori hanno modificato il parametro che
limitava a 1 mb il singolo blocco della blockchain di bitcoin, alcuni
hanno seguito questa modifica, altri (la maggior parte) no, da quel
momento esistono due bitcoin, Bitcoin (blocchi dati da 1 mb) e
Bitcoincash (blocchi dati molto più grandi fino a 10 mb)
Nel 2016 un utente sfruttando una vulnerabilità in uno smart contract
scritto nella blockchain di Ethereum (the DAO) è riuscito ad
impossessarsi di un ingente importo destinato da alcuni utenti ad
investimenti. La fondazione che controlla Ethereum ha deciso di
annullare questa operazione (e tutte quelle successive) eliminando un
pezzo delle blockchain, molti hanno seguito questa nuova versione, una
minoranza è rimasta “fedele” alla versione contenete la transazione
definita illecita. Da allora esistono due blockchain di questa valuta,
Ethereum e Ethereum Classic.
Esempi di fork condivisi sono numerosi e meno eclatanti, e hanno
portato modifiche che hanno migliorato il funzionamento in maniera
quasi trasparente per l’utente, qualcosa di molto simile a un
aggiornamento dei programmi che avviene periodicamente sul nostro
computer.
La governance del consenso di alcune criptovalute
Ogni blockchain e quindi ogni comunità ha una modalità per gestire gli
aggiornamenti ed ottenere il massimo consenso possibile in modo da
evitare frammentazioni potenzialmente dannosi per l’integrità e la
crescita della blockchain.
Riporto di seguito degli esempi, per ovvie ragioni riassunti, di come
diverse comunità gestiscono questa esigenza.
Bitcoin
A fronte di una modifica potenziale elaborata da un team di
sviluppatori (BIP Bitcoin Improvement Proposal), i miners votano la
proposta in essere valorizzando un apposito campo nel blocco appena
creato, si ha modo quindi di valutare la popolarità di una proposta
contando i miners favorevoli. Il voto però non è capitario (1 miners 1
voto) ma proporzionale alla potenza di calcolo espressa da ogni miners.
Nel caso, precedentemente citato, particolarmente controverso le due
fazioni (UASF vs bigblokers), impegnate anche in una piccola
“campagna” per coalizzare il consenso, si contesero il predominio
della scelta evolutiva nell’ambito di una riunione dei rappresentanti
degli sviluppatori e dei miners, per decidere l’adozione o meno della
modifica della size del blocco. La decisione di compromesso fu quindi
prettamente “politica”, la decisone stessa fu poi ratificata con una
richiesta di voto da parte dei miners che, se d’accordo, scrivevano
NYA (New York Agreement) nell’apposto campo del blocco minato. Un
gruppo minoritario ma rilevante non approvò questa decisione e diede
origine ad una biforcazione.
Potenzialmente ogni parametro conosciuto di Bitcoin potrebbe essere
modificato, anche quelli con conseguenza rilevanti sul valore della
moneta, come ad esempio la modalità produzione quotidiana di valuta,
la così detta inflazione delle criptovalute. La salvaguardia della
integrità del valore della moneta è affidata a due principi logici e
matematici in parte derivanti dalla teoria matematica dei giochi:
– I decisori (miners) sono fortemente coinvolti e partecipi del valore
della moneta e sarebbe contro i loro interessi approvare iniziative
contrarie all’interesse delle comunità
– Una decisione approvata, che portasse vantaggi a una parte
minoritaria della comunità, condurrebbe ad un fork contenzioso della
parte maggioritaria e danneggiata, abbandonando gli organizzatori del
“colpo di stato” con una blockchain e una valuta inutilizzata e quindi
probabilmente fortemente svalutata.
Ethereum
Le decisioni vengono prese dalla fondazione che ha creato Ethereum
dopo una consultazione con la comunità. Sono attualmente in corso
modifiche molto rilevanti su aspetti sostanziali (passaggio a da Proof
Of Work a Proof of Stake), la decisione è stata presa dopo una
consultazione con la comunità.
La fondazione e il suo leader nonché inventore, Vitalik Buterin,
agiscono come un sovrano illuminato che prende decisioni per il bene
di tutti dopo una consultazione non vincolante con la comunità.
Ripple
La società che ha inventato i Ripple e ne detiene la maggioranza
decide autonomamente modifiche del software o di altri parametri, ad
esempio al momento detiene 50 miliardi di monete in un conto segregato
e sta valutando se annullarle, dimezzando così il totale delle monete
esistenti.
Polkadot
Ha elaborato un articolato sistema di consenso della comunità che
prevede l’interazione tra il concilio (24 membri eletti dalla
comunità) e i detentori attivi della moneta (utenti che bloccano le
loro monete in prossimità del voto) per gestire le innovazioni. La
votazione prevede numerose regole su come contare i voti e su quali
maggioranze siano qualificate per ogni tipo di modifica.
Conclusioni
Un insieme di modalità di governance diverse tra di loro e in buona
parte giovani e acerbe, poco testate nella pratica rende difficile
estrapolare delle conclusioni univoche. Possiamo però trarre almeno le
seguenti considerazioni:
– Il software è modificabile
– Le modifiche non sono neutrali sulle caratteristiche della moneta
– Le modifiche sono decise dalla parte attiva della comunità e hanno
conseguenze su tutti gli utenti
In dettaglio possiamo dire che, le tecnicalità di gestione delle
blockchain sono modificabili nel tempo e tali modifiche possono
variare aspetti così rilevante da incidere pesantemente sul valore
economico della criptovaluta sottostante.
Gli individui o gli enti deputati a gestire il cambiamento svolgono un
ruolo simile ai governi nazionali o alle banche centrali nel mondo
delle valute FIAT.
Tanto maggiore è la concentrazione del potere decisionale in un gruppo
ristretto di figure, tanto più lontano dall’idea rivoluzionaria di
Satoshi diventa la governance delle blockchain. Ovvero l’idea che il
principio degli interessi contrapposti e concorrenti possa evitare che
una oligarchia prenda il sopravvento sulla maggioranza degli utenti
verrebbe meno.
A questo proposito vale la pena riportare un’analisi effettuata
dall’università di Cambridge (https://cbeci.org/mining_map) su un
aspetto di questa concentrazione sulla rete di Bitcoin. Tale
monitoraggio attualmente riesce a tracciare un po’ meno della metà
della potenza di calcolo mondiale dedicata al mining, da questa
analisi emerge che il 65% della potenza di calcolo di questo campione
è concentrata in Cina al secondo posto molto distaccati troviamo gli
USA 7%.
Scenari futuri
L’introduzione di concetti come “cloud” “mining” o “valute digitali”
hanno diffuso nel pensiero comune l’idea, molto lontana dalla realtà,
di attività o beni del tutto eterei e immateriali lontani dalla
fisicità. Mentre dati e informazioni transitano su cavi fatti di fibra
ottica e risiedono su apparati realizzati in metallo e custoditi con
attenzioni dalle nazioni leader mondiali, ad esempio i principali cavi
dati sottomarini sono posati da enti americani e pattugliati dalla
flotta militare Usa. L’ubicazione geografica dei server che contengono
i dati dei social network che tutti usiamo è oggetto di aspre contese
tra gli Usa e le altre potenze emergenti.
Sembra incoerente, che le grandi potenze abbiano finora tentato di
controllare il mondo delle criptrovalute tramite norme nazionali, un
tentativo destinato a fallire per la natura sovranazionale e
distribuita delle blockchain. Mentre non abbiano ancora,
ufficialmente, tentato un controllo sulle attività più fisicamente
individuabili, come il mining.
Azzardando una analisi geopolitica sugli scenari evolutivi del
controllo delle criptovalute possiamo ipotizzare che qualunque ente o
governo che volesse controllare o almeno influire sulle scelte
evolutive di una criptovaluta non avrebbe altra scelta logica se non
quella di coinvolgersi nella sua amministrazione, ad esempio per la
blockchain di Bitcoin tramite un coinvolgimento nel mining. Una sorta
di attività di “mining istituzionale”.
In conclusione possiamo dire che la conoscenza profonda dei metodi di
governance di una blockchain unita alle risorse di uno stato o ente
sovranazionale potrebbero di fatto consentire a quella realtà di
mettere sotto il proprio “controllo” una criptovaluta, andando a
influire sulla gestione monetaria di una valuta usata al di fuori dei
propri confini, e nel caso di Bitcoin sempre più diffusa a livello
mondiale.